Le leggi di Keplero: album da ascoltare (e riascoltare) in quarantena
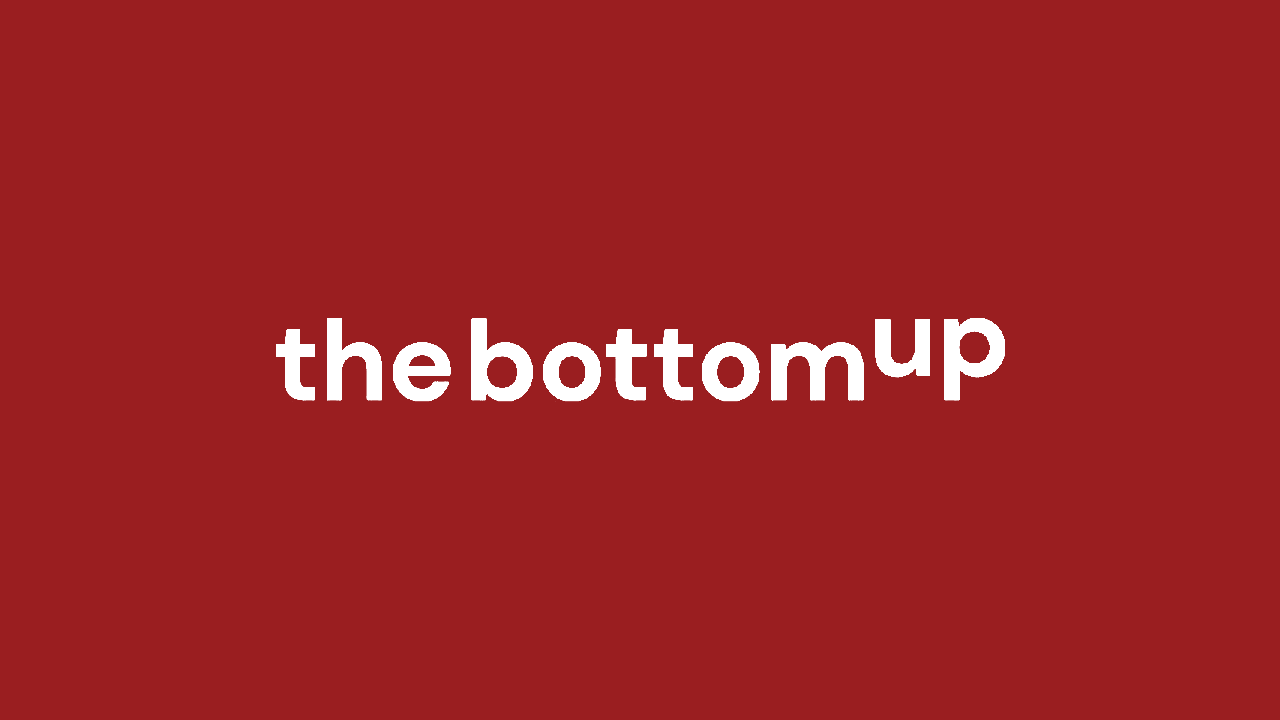
, questi giorni di quarantena sono per me una grande occasione di ascoltare, o riascoltare, : alcune cose nuove, moltissime vecchie, alcune già nella mia rotazione regolare, altre riscoperte. Qui ne scelgo cinque, sperando che anche voi scegliate di è principalmente noto per essere il capo dei Primus: una band assolutamente , testualmente e sonoramente, le cui fondamenta sono basate sul basso virtuoso e inventivo e sulla dello stesso Les. Tra la fine degli anni 90 e il ritorno dei Primus verso metà degli anni 2000, Les ha variato le sue collaborazioni producendo anche qualche disco più o meno solista. , che includeva batterista e chitarrista originali dei Primus, Jay Lane (che poi ci è brevemente tornato nel 2011 per e il rispettivo tour, che fece tappa a Pordenone, dove proprio Lane mi autografò il disco – ma sto divagando) e Todd Huth, era funzionale a suonare ad alcuni festival estivi, ma generò anche tre dischi, o meglio, due mezzi dischi dal vivo e uno intero in studio, , si apre con una cover dei King Crimson e si chiude con una divertentissima versione di dei Pink Floyd. Prima di lasciare il palco, Les annuncia che torneranno con “più Pink Floyd di quanto sarebbe lecito tollerare per qualunque umano” dei Pink Floyd. Se conoscete i Primus potreste avere dei legittimi timori sul risultato sonoro di questa avventura, eppure è meraviglioso. Lane valorizza all’estremo le semplici linee ritmiche di Nick Mason, e Claypool trasforma gli ipnotici giri di basso Watersiani in qualcosa di ancora più potente – dimostrando inoltre una vocalità sorprendentemente simile all’originale e a tratti quasi irriconoscibile rispetto alla sua solita impostazione paperinesca. Un ascolto coinvolgente e divertente! Gli ultimi tre dischi di De André sono dischi di viaggio per chi ascolta, e sebbene l’unico esplicitamente dedicato a una terra, a una città, Genova, sia , curioso pastiche di generi e umori, a trasportare l’ascoltatore più del predecessore e del successore ( , molto più spirituale, e il disco che scelsi per attraversare l’aeroporto di Rio De Janeiro, tornando a casa dopo cinque mesi in nave, ormai più di due anni fa). Si comincia con la malinconica introduzione che descrive le nuvole titolari, per poi venire trasportati su un palco di commedia con (entrambi brani arrangiati e suonati alle tastiere da Sergio Conforti – bravi, avete indovinato: di Elio e le Storie Tese). Il lato A si conclude con la struggente e potentissima , sorta di elegia a descrizione dell’Italia degli anni ’80 appena conclusi. Il lato B è forse meno politico, ma si apre con la coinvolgente (Medico Medicone) che ci riporta a Genova (e ha un testo scritto con l’amico Ivano Fossati, che collaborerà poi a , che però da’ un po’ di necessario respiro. Il disco si conclude con , canzone che racconta, in dialetto gallurese, una storiella ambientata nell’odierna Costa Smeralda: un uomo si innamora di un’asina bianca, con la quale non riesce però a sposarsi, nonostante tutto il paese abbia già organizzato il matrimonio. Dallo scartabellare nella burocrazia, viene fuori che i due sono parenti stretti. La canzone, raccontata così, pare essere poco più che una burla, eppure è la conclusione quasi epica del disco, e più di ogni altra melodia qui riesce a trasportare l’ascoltatore sui Monti di Mola, a guardare il mare, con le nuvole che si specchiano sull’acqua. Bisogna pur tirarselo su, il morale! Dopo i classici degli esordi ( ), uno dei migliori dischi di Elio e le Storie Tese, arrivato dopo una prova non entusiasmante ( ), è stato il disco che me li ha fatti conoscere (grazie a Vincenzo che all’epoca me lo presentò). Quasi tutte le idee del disco sono geniali: l’omaggio al prog di , la cover al contrario di Suspicious Minds di Elvis Presley, (che è anche una mini suite cantata in larga parte con lo stile del Trio Lescano), , diventata uno degli inni dal vivo della band, e la spettacolare – vi sfido a non agitare almeno un po’ il culo! Un tour de force di comicità volgare e dissennata, che ogni tanto ne abbiamo proprio bisogno. (seppure in uno dei pochi brani sotto la media del disco): di certo non lo fanno gli Opeth, che su questo loro album dividono in egual misura l’output sonoro , e ce n’è per tutti i gusti. Il disco si apre con la dolce e malinconica , cantata dalla fidanzata del nuovo batterista Martin Axenrot, che però sfocia dopo un paio di minuti nella devastante , ben più affine agli stilemi prog death. Segue la funkeggiante , con un break di clavicembalo che Led Zeppelin levatevi, ma non temete, fan della mestizia, perché sta per arrivare la ballatona con dei mellotron estremamente lacrimevoli e un Åkerfeldt espressivo come non mai. , se non è la miglior performance vocale di Mikael fino a qui, ci si avvicina decisamente: e accompagna un groove di chitarra e tastiera ipnotico. vi tira la badilata in faccia che vi mancava, se siete sopravvissuti fino a qui, mentre assicura una chiusura di album moderatamente serena. Ed ecco che siete stati mondati dalla tristezza, immergendovici totalmente (anche se sono convinto che un gran lavoro l’abbia fatto il death metal). Una curiosità: sul retro del disco c’è una faccia che ancora oggi turba il mio sonno: sono le facce dei cinque membri della band mischiate a formarne una sola, ed assomigliano a : ma questo disco l’ho ascoltato un numero di volte, diciamo elevato, da quando è cominciata la pandemia mondiale. A questo punto i Rush avevano rotto il muro dei sintetizzatori: c’era della tensione tra Geddy e Alex sulla quantità dei medesimi. Il chitarrista era legittimamente preoccupato che le infernali apparecchiature gli rubassero il posto sulla scena, mentre il bassista voleva ampliare i suoi orizzonti il più possibile. Nel registrare il seguito di , però, il trio riesce a ottenere un ibrido delle due visioni assolutamente eccezionale. Le tastiere sono chiaramente più esposte, eppure il disco funziona così bene solo ed esclusivamente grazie alle chitarre graffianti di Lerxst. Il titolo del disco viene da una citazione semi-apocrifa di : Neil ne restò impressionato e propose l’idea ai compagni, che la approvarono. Il tema dell’album è proprio quello, mantenere il coraggio in tempi bui, che fossero quelli degli ultimi anni di guerra fredda, raccontati nell’opener (un brano che invecchia meglio di quanto si possa pensare a un primo ascolto: sentite la coda di basso e batteria finale!), o quello della madre di Geddy, sopravvissuta dell’olocausto, durante la prigionia nel campo di Bergen-Belsen, raccontato in è un omaggio a un tecnico dello studio, amico di Neil, dove i Rush hanno registrato l’album, scomparso in un incidente d’auto pochi mesi prima delle registrazioni. ). Peart scelse di scrivere i tre brani partendo dall’ideale conclusione affrontando prima i temi meno complessi: parla della paura di ciò che abbiamo dentro (no, non il dirigibile marrone di Elio) e Peart volle dedicarci più tempo possibile. , con un titolo ispirato da una poesia di Whitman, ha un testo che rimanda invece a di Philip K. Dick, di ispirazione anche a Ridley Scott per il suo sembra quasi essere stata messa in piedi per dar modo ad Alex di sbizzarrirsi con e giocoso, ed è uno dei brani meno in contesto del disco, ma non per questo meno coinvolgente. L’album si conclude con la potentissima , uno sguardo cupo ma speranzoso sulle ruote del tempo, tra le quali spesso ci ritroviamo schiacciati, in eventi più grandi di noi: il giro di tastiere è uno dei più memorabili di tutta la carriera della band, ma è la performance vocale di Geddy che si porta via tutto er cucuzzaro:
