Dulcis in fundo… – In Cauda Venenum, 2019
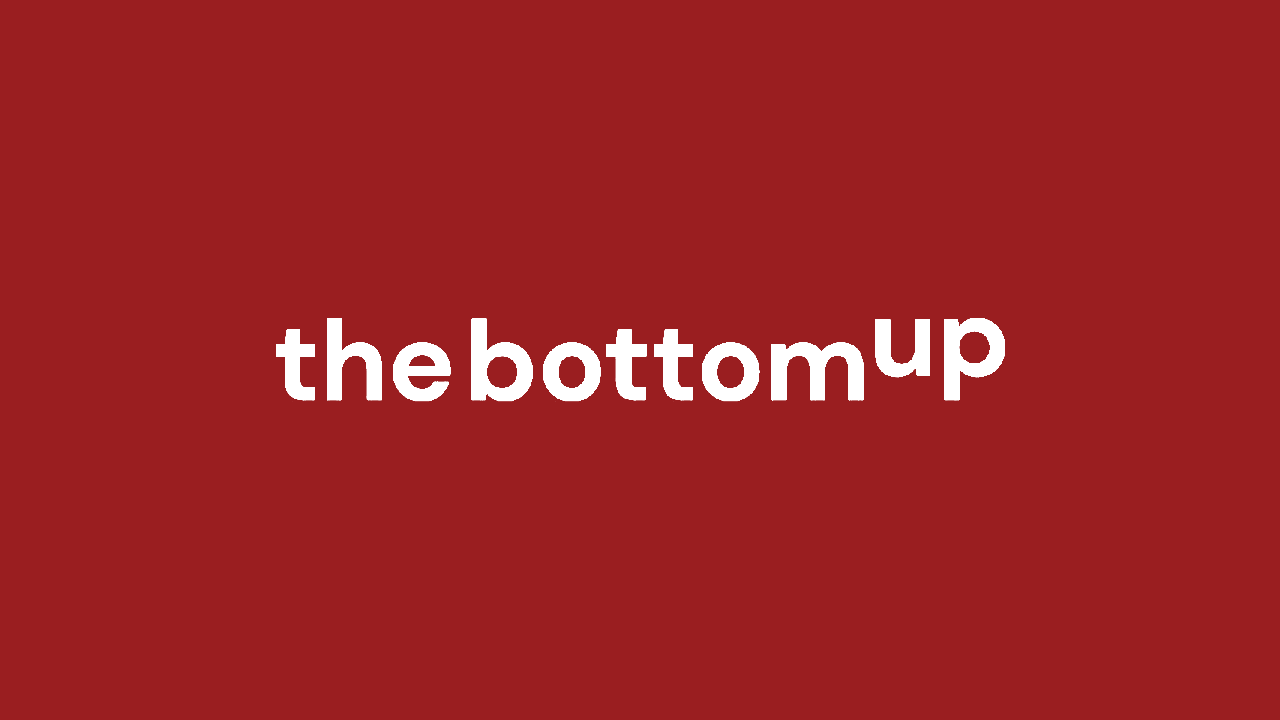
chi ama la musica dovrebbe trovarsi un lavoro vero, come ad esempio l’idraulico . All’epoca Fripp era probabilmente ancora impelagato in alcune schermaglie legali, e soprattutto stava studiando come avere introiti sufficienti alla sua soprvavvivenza pur suonando il cavolo che gli pareva. , evidentemente ha trovato un modo di far coesistere le due cose. Basta vedere come, nell’episodio di dei quali è protagonista, descrive i dischi che ha appena comprato o il suo Questo suo amore traspare, naturalmente, ancora di più nei dischi della sua band, che di fatto è un veicolo per le sue idee artistiche ormai da moltissimo tempo: se nei primi anni c’era un’atmosfera vagamente collaborativa, a partire da , del 2008, Mikael aveva cominciato a lavorare a un seguito sempre in forma del progressive death metal che era ormai il suono tradizionale della band: non era del tutto convinto, però, e il bassista (ormai con la band dal 1997, il più longevo dei membri attuali) confidò a Mikael che sarebbe stato deluso se avessero fatto un altro album così. Confortato da ciò, il nostro si mise al lavoro su quello che sarebbe poi diventato , del 2011, e aprì la strada alla vena puramente progressiva degli Opeth (se si esclude lo splendido , contrapposta a “dulcis in fundo” (ora lo avete capito, il brillante giuoco di parole del titolo?), a identificare situazioni in cui sembra che il peggio sia passato e invece arriva proprio alla fine . Il suo significato non è molto chiaro, anche se, personalmente, ho una teoria un po’ paurosa che lo vede come Mentre la lavorazione dell’album procedeva silenziosamente, in qualche fugace apparizione a mezzo stampa online, Mikael suggeriva che avrebbe provato qualcosa di malvagio che in realtà letteralmente significa ‘contorto’), e naturalmente i pochi sciamannati che ancora speravano (invano) che gli Opeth tornassero a fare death metal avevano gridato al miracolo. La contorsione, invece, era linguistica: al corso prog degli Opeth. Non parlando svedese, ovviamente ho appena una vaga idea del significato dei testi dell’album, ma è proprio questo che secondo me è perfetto. Non potendosi concentrare sul significato delle parole, si è costretti a concentrarsi sul significante, sui suoni, così melliflui e misteriosi , della lingua scandinava qui utilizzata, e sulle melodie create per queste trame sonore dall’aria solo apparentemente nostalgica. E qui arriviamo al punto cruciale: è vero che il tessuto di questo album, come dei tre precedenti, è estremamente ispirato, quando non derivativo, dalla musica progressiva degli anni ’70, eppure qui si sentono, forse per la prima volta, i quasi trent’anni di musica prodotta dalla band amalgamarsi alla perfezione, nel disco della maturazione prog. Come . Su questo album torna anche una produzione più adeguata: dopo la parentesi di Tom Dalgety su , che ha portato a un sound inutilmente gommoso (sentite i brani di !), viene fatta giustizia ai due Martin, Mendez e Axenrot (quest’ultimo il batterista), e l’orchestra, come su È un disco senza compromessi – se non vi piace il prog, non vi piacerà – a parte uno, che francamente mi ha spiazzato e un pochino deluso: , con i testi e le linee vocali inevitabilmente cambiate e riarrangiate. Nuclear Blast aveva paura che la gente non lo comprasse perché era in svedese? Hai avuto paura di Nuclear Blast? Non riesco proprio a capacitarmi che la stessa persona che ha avuto il fegato di far uscire un si sia poi piegato a queste logiche commerciali ridicole (lui dice di essere stato lui ad avere paura, ma io non gli credo: ). Vedo anche qualche recensore, come dire, sciocchino, che definisce la versione svedese una bizzarria per impallinati, quando lo stesso Åkerfeldt ha dichiarato che l’unica versione vera è quella in svedese, e infatti è quella esaminata in questa recensione. soddisfano il desiderio di cattiveria, e il brano più interessante, perché devia completamente dall’aspettato, è . Eppure, il brano probabilmente più intenso dell’album è “Minnets yta”, una ballatona che mostra l’Åkerfeldt più di sempre e un Joakim Svalberg alle tastiere sempre più coraggioso, seguito a ruota dalla conclusiva, già menzionata, “Allting tar slut”, con il suo liberatorio crescendo finale (che sembra quasi – possibile? – In Cauda Venenum, in estrema sintesi, dimostra come gli Opeth siano in grado, come pochissimi altri, di seguire quella “ , che li porta a poter esplorare gli spazi infiniti della musica popolare contemporanea senza limiti e senza confini, con
