Da un ricordo: Metropolis pt. 2: Scenes from a Memory, 1999
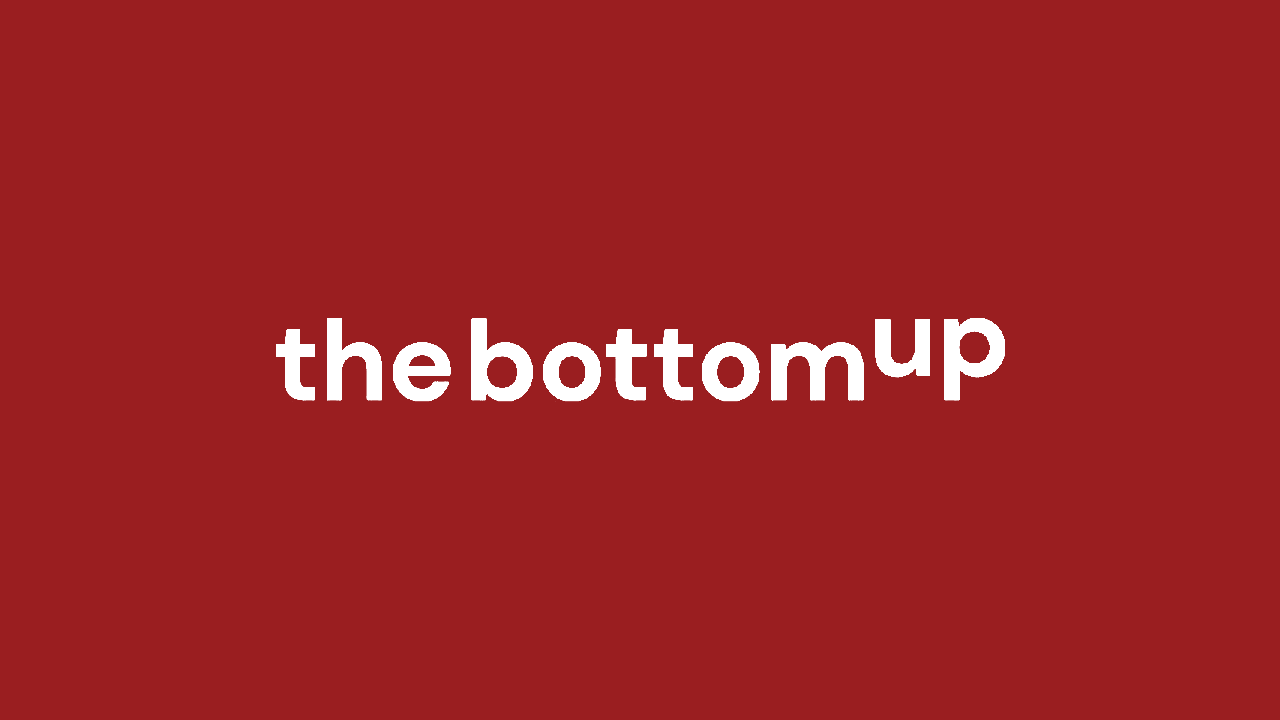
c’è gran dibattito all’interno della comunità metal, all’interno della comunità prog e all’interno della comunità prog metal: cioè, ci sarebbe se esistessero delle entità così ben definite. I Dream Theater sono una band americana fondata nel 1989 da (tastiere) e Charlie Dominici (voce). Dopo il primo album, già foriero di grandezza ma tutto sommato acerbo, i Dream Theater, sostituito Dominici con il canadese , uno dei dischi più belli e più importanti (se non IL più importante) del Con il disco successivo la band cementa la propria reputazione di del nascente progressive metal, ma a disco appena pubblicato, a detta di tutti piuttosto a sorpresa, Kevin Moore lascia la band, ma soprattutto l’amico di una vita Petrucci. Quest’ultimo e Portnoy, dunque, oltre a doversi ingegnare a trovare un nuovo tastierista, ne prendono il posto come (metà suite prog metal, metà cover live di classiconi del rock), con a bordo Derek Sherinian alle tastiere, la band ha un semi-fallimento con , un disco piagato dall’interferenza con i discografici e sul quale Sherinian non si trova particolarmente a suo agio, vuoi per le interferenze di cui sopra, vuoi per lo stile radicalmente diverso da quello ricercato dai suoi compagni, vuoi per l’inevitabile confronto con Moore. Sherinian lascia subito dopo il tour promozionale (dal quale viene tratto il live alle tastiere, e liberatisi di qualsivoglia ingerenza discografica, i due capitani Petrucci e Portnoy guidano la band verso l’ignoto, partendo da alcuni pezzi scartati dalle sessioni di che avrebbero dovuto essere una mini suite. Lo spunto viene dal brano più grande della loro intera discografia (a oggi), “Metropolis, Pt. 1: The Miracle and the Sleeper”, intitolato così a immagine e somiglianza dei loro idoli (un fatto curioso: il produttore storico dei Rush, Terry Brown, co-produrrà le parti vocali dell’album), ma senza mai la vera intenzione di realizzarne una seconda parte. Partendo dunque dalle idee musicali presenti nella prima parte, il tema viene espanso fino a creare un , oltre che il punto di arrivo del primo decennio di carriera della band. La storia del disco riprende vagamente i personaggi presenti nella “prima parte”, Nicholas e Victoria, che vivono rispettivamente nel presente e nel passato (Nicholas è la reincarnazione di Victoria?), e l’intreccio delle loro due linee temporali. La storia del concept, per quanto costruita maniacalmente da Petrucci e Portnoy, e rappresentata anche dall’ , spesso collaboratore di Neil Gaiman, è però tutto sommato marginale nell’importanza di questo album. Ciò che davvero impressiona, qui, è la musica. o freddezza, e anche per un estimatore come il sottoscritto è difficile negare che sia accaduto qualche scivolone in questo senso. Eppure qui la band è . LaBrie è in splendida forma (nonostante un incidente con del pesce palla che gli danneggiò le corde vocali durante il tour di ), duttilissimo nell’interpretare i personaggi del concept, aggressivo o dolce in base alla necessità del momento. L’ultimo arrivato Jordan Rudess, pur avendo uno stile completamente diverso rispetto a quello sobrio e delicato di Moore (che io, per dire, preferisco), qui splende assolutamente, non invadendo mai il campo sonoro eppure lanciandosi in assoli funambolici e parti circensi come quella, epica, di , leggendario e complicatissimo strumentale e forse chiave di volta dell’intero album. , complice uno stile bassistico virtuoso eppure delicato (molto spesso penalizzato nel mix, come accade anche qui, seppure in misura minore che su altri album): eppure le sue linee sono fondamentali per la sezione ritmica. Qui scrive anche quello che sarebbe stato per molti anni (fino al 2011) il suo ultimo testo, quello di “Fatal Tragedy”. Inaspettatamente non proseguo con la sezione ritmica (vedremo perché), ma osanno qui , che trova qui la sua perfetta realizzazione. Ci sono riff indelebili, sia quelli più sognanti che quelli più cattivi, una sintesi perfetta dei quali si trova nell’altro brano più rappresentativo dell’album, “Home”, citazioni (su “Beyond This Life”) e assoli devastanti (su tutti proprio quelli di “Beyond This Life” e “Home”). Petrucci più di tutti viene accusato di essere nel suo stile, ed è vero che in alcuni momenti (quasi tutti successivi a questo disco) la tecnica sembra prevalere sull’emozione. Non è però il caso qui, dove dimostra a pieno titolo di essere davvero , il musicista che più di tutti gli altri rende così importante e, soprattutto, così bello questo album: il batterista , dimostrandosi, seppure per un attimo fugace, il vero possibile erede di un mostro sacro come , al quale viene spesso paragonato. Chiariamoci: il paragone è sbagliato per molti motivi, ma qui, in questo momento nel tempo, non lo è. Su (che è proprio ciò che caratterizza Neil, che però è stato consistente in questo per tutta la sua carriera, diversamente da Mike). su nessun album pubblicato successivamente, dalla band o da uno degli ottocentosettantaquattro side project di Mike. Se fossi costretto a scegliere L’idea di questa recensione vintage mi è venuta, oltre che per festeggiare il ventennale dell’album che cadrà tra poco più di tre settimane , come aveva fatto all’uscita. Per quanto vorrei provare l’emozione di sentire questo album suonato dal vivo, però, non andrò. I più scafati di voi, infatti, sanno che da ormai 9 anni, e una performance del suo capolavoro senza di lui (sostituito, peraltro, dall’ipertecnico e un po’ asettico Mike Mangini) non avrebbe senso. Fortunatamente, ho il disco che posso riascoltarmi quante volte voglio, cosa che faccio da quando lo possiedo, e ricordo ancora la prima volta che lo ascoltai, dopo averlo comprato alla Feltrinelli di Udine (quando aveva ancora una selezione di dischi piuttosto ampia). Avevo un lettore CD portatile, di quelli a forma di disco volante , tornando a casa da scuola. Allora l’unico altro album della band che avevo era , dunque sapevo bene di cosa fossero capaci, e mi esplose comunque il cervello. Se anche non siete progster nerd come me o metallari invasati, sempre come me, o banalmente non avete mai ascoltato
